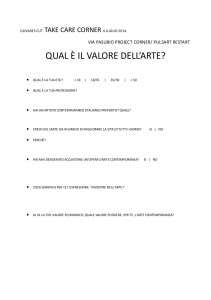Posts Tagged: Take Care Corner


Olivares cut @ PULSART RESTART
Take Care Corner è il progetto che Olivares cut portò nel 2013 ad ArtVerona fiera, nell’angolo che, nella sezione “blogger”, Independents le aveva riservato. Uno spazio intimo ed accogliente, pur nell’ambiente caotico di una fiera, all’interno del quale riflettere sull’arte e dialogare in modo diretto, ravvicinato, con artisti e curatori.
Olivares cut, ospite di Pulsart all’interno di Via Pasubio Project Corner, vuole ricreare un angolo dove poter discutere di arte ma, in questo particolare ambito, il dialogo avverrà con il pubblico: chi desidererà fermarsi a parlare nel salottino potrà rispondere ad alcune brevi domande che stimolino l’interesse e il dibattito nei confronti del “valore dell’arte” e portare le proprie riflessioni e considerazioni sull’argomento.
All’interno di un sistema in preda a una generalizzata “crisi di valori” la domanda “che valore ha l’arte”, per ciascuno di noi, non necessariamente coincide con l’interrogativo “quanto saremmo disposti a spendere per un’opera d’arte”, ma piuttosto con la domanda “quanto conta l’arte nella nostra vita?”. L’arte è un valore aggiunto o un vuoto a perdere?
A partire da questi interrogativi si svilupperà il progetto del secondo episodio del Take Care Corner di Olivares cut.
“Venerdì 4 luglio
in occasione della giornata di inaugurazione di
PULSART RESTART 2014
via Pasubio Alta si trasformerà in zona pedonale
diventando un percorso che unirà Lanificio Conte, spazio Shed e Palazzo Toladi
attraverso il quale potrete conoscere i protagonisti di alcuni tra i più interessanti progetti indipendenti del momento.
Verranno allestiti per l’occasione dei salottini, luoghi fisici che permetteranno l’incontro tra le realtà culturali indipendentiattive nel mondo dell’arte e della cultura e il pubblico.
Basterà sedersi e chiacchierare con loro per immergersi nei processi creativi che hanno generato i progetti culturali che abbiamo deciso di presentarvi.”


Sporcarsi le mani
Davanti alla bocca spalancata del forno stavano due ragazzi, a scrutare con una certa apprensione il caldo crepitio che accendeva di rosso le guance più di quanto non stesse facendo il vino versato nei loro bicchieri. Sotto allo specchio in ingresso, quello con l’enorme cornice in algida ceramica smaltata, stava accatastato qualche buon quintale di ciocchi di legna grossi come cosce, pronto per essere arso. Dovevano assicurare il carico per le quattordici ore successive. Nonostante i turni pronti da giorni, nessuno sarebbe stato in grado di andarsene prima che la cottura fosse stata ultimata, magnetizzati dal fascino della fornace e dalla sospensione greve che crea l’attesa di un evento…
Arrivando a Nove in auto da Vicenza, contavo sulla punta delle dita da quanti anni non andavo alla Fornace Stringa. Forse dieci, forse di più, che importa. Al tempo frequentavo ancora l’università. Nadir Stringa, il proprietario della fornace, era fratello di uno dei miei professori di corso, il buon Nico, detentore della cattedra di Arte Contemporanea in quel di Ca’ Foscari.
La produzione ceramica, all’interno della fornace, era interrotta già da anni, ma i proprietari avevano avuto la saggezza e la cura di preservare gli spazi e i manufatti dall’incuria e l’abbandono mantenendo, per quanto possibile, inalterata la storia di uno dei più importanti centri di produzione ceramica nazionale, se non addirittura internazionale. La prima volta che andai, ricordo, mi rimase impresso il fatto che stessero cercando, per mezzo mondo, chi potesse sistemare la ruota idraulica, composta da tavole lignee ormai rose risalenti a qualche secolo prima. Un pezzo di storia nella storia.
Ogni anno la cittadina, che poco dista dalla più conosciuta Bassano, apre i portoni delle fabbriche dove ancora si produce ceramica, salvaguardando la tradizione decorativa e la manualità che negli ultimi decenni la produzione industriale è stata in grado di spazzare via per la gran parte. A fianco di chi – gli anziani novesi – non ha mai smesso di esercitare una pratica tramandata di padre in figlio, da qualche centinaio d’anni (uomini che hanno passato una vita chini sui piatti, o donne dalle dita piccole e affusolate in grado di assemblare con minuziosa precisione piccolissimi elementi di terra molle) esiste una piccola frangia di “novesi di ritorno”. Uomini, una manciata, tra i trenta e i quarant’anni, cresciuti tra le mensole di legno sulla quale riposavano le terrecotte uscite dai forni, tra gli odori delle vernici usate per le decalcomanie – le stesse da secoli – e i rigoli d’acqua e terra che colavano dalle griglie di legno, che avevano tutto l’aspetto di scale a pioli messe a riposo, irrorando i pavimenti delle manifatture come campi assetati.
Made in Nove, così si è ribattezzato questo gruppo. Come fosse un marchio di qualità, una garanzia sottopelle, un sangue blu screziato di argilla. Ragazzacci dell’arte che, prima di tornare alle origini per calarle nel contemporaneo, si sono allontanati da queste cercando la loro personale strada.


La presa ferma
Intro.
Ti ho riconosciuto nell’atrio della fiera, nell’andirivieni di gente ininterrotto che ti circondava. Tu eri al telefono e io ho pronunciato il mio nome senza emettere suono, per non disturbare la conversazione. “Petra”. Letto il labiale, hai chiuso la chiamata e ci siamo presentati come si conviene. Una stretta di mano, due baci sulle guance. Quelle cose che si fanno quando ci si vede per la prima volta, dopo essersi scambiati il giusto numero di messaggi scritti e una telefonata per capire dalla voce di che pasta si è fatti.
Accettando il mio invito venivi a parlare di te al Take Care Corner (“no, di Dolomiti Contemporanee“, mi hai risposto. “Ma io volevo che mi parlassi di te”. “Io Sono Dolomiti Contemporanee.” “Ah, allora va bene”). Ti ho guardato sederti in poltrona e, in un tempo brevissimo (chissà se te ne sei accorto) calamitare attorno a te le persone che gravitavano attorno ai tappeti, alla lampada. Tutti si sono fermati ad ascoltare ciò che ci stavi per dire.
Iniziamo.
Gianluca D’Incà Levis è un fuggitivo. Un architetto fuggito dalla morsa del tecnigrafo.
Nel 2008, mentre l’Unesco stava valutando la possibilità di far rientrare nel patrimonio dell’umanità il complesso naturale dei “Monti Pallidi”, Gianluca usciva dal suo studio di architettura per entrare nel tunnel dell’arrampicata.
Io non ho idea di che significhi “arrampicare”; mi dicono sia un’esperienza totalizzante, mistica, di quelle di cui, una volta provata, non si riesca più a farne a meno. Uno spaccio di endorfina.
In un volo pindarico, guardando dal basso i corpi appesi alla roccia, cerco un’analogia tra questa pratica a me così lontana e il tango che conosco. Vedo in loro, come nella danza, una tensione del corpo che è dettata dalla mente, la quale riferisce ai muscoli che fare attraverso parole silenziose; l’incedere sicuro, un passo alla volta, è scandito da un ritmo fatto dai suoni del respiro. Le spalle rilassate, i polsi morbidi, i nervi tesi, la presa ferma: si seduce la roccia per conoscerla. La corda doppia fa una ronda verticale. Le cortine lassù, anziché esser musicali, sono di nebbia.
Accosto l’immagine della presa nel tango (le mani unite dei due ballerini nell’abbraccio) a quella nell’arrampicata, quando le falangi stringono la roccia sfidando le leggi di gravità. E trovo in Walter Benjamin la riprova che le coincidenze esistono (se le si vogliono trovare): “La presa ferma, apparentemente brutale, fa parte dell’immagine della salvezza.”


Chirurgo della luce
Al momento di andarsene, Andrea Rosset, primo ospite del Take Care Corner ha detto che questa chiacchierata di oltre un’ora e mezza avremmo potuto farla a casa. Ma, assieme a me, ha convenuto che non sarebbe stato lo stesso. Stavolta non gli è bastato, come fa di solito, scendere due rampe di scale, aprire il portoncino d’ingresso, uscire in strada, fare circa sette passi sotto la linea delle mie finestre e suonare il campanello, per venirmi a raccontare del suo lavoro artistico. La scelta stavolta ricadeva nell’accettare un invito che prevedeva un coinvolgimento diverso. Si trattava, ossia, di attivare un discorso “ravvicinato” sull’arte (gli interlocutori eravamo noi due) ma potenzialmente sotto gli occhi di tutti. L’idea del Take Care Corner è stata quella di traslare in un luogo affollato, con un pubblico vario e di passaggio com’è quello di una fiera, una modalità di interazione che mantenesse idealmente una dimensione quasi intima, funzionale all’ascolto. Prendendomi cura dell’artista (in questo caso prestando ascolto, attenzione, alle parole dell’artista sul suo lavoro) mi prendo cura dell’arte.
“Chi è, la donna della foto?”. E che importanza ha? La prima domanda è mia, la seconda è il condensato della risposta di Andrea. Per parlare del ventennale rapporto con la fotografia di Andrea ho scelto di cominciare lasciando fare a lui stesso delle considerazioni su un suo progetto in particolare, Restrain. E per farlo ha portato con sé una piccola stampa, trenta centimetri per quaranta nella quale è rappresentato il volto di una donna piegato leggermente da un lato, lo sguardo basso sembra seguire il flusso dei pensieri; le spalle che appaiono nella foto sono nude, i capelli escono da una macchia d’oscurità, in cui tutta la sagoma è immersa. E’ difficile, guardando un ritratto, non porsi interrogativi sull’identità del soggetto, come se un’informazione biografica consegnasse un valore aggiuntivo al fine della contemplazione dell’opera. Ma non è questo il punto, non per Andrea.
La ricerca in merito alla fotografia contemporanea di Andrea si compie sul livello del linguaggio: attraverso un lavoro lungo e meticoloso, da tempo lui opera per trovare una modalità esecutiva che conceda al fotografo di allontanarsi sempre più con migliori esiti, dal “predominio dell’occhio”. Sembra un paradosso, eppure nel distaccarsi dall’operazione meccanica che il mezzo implica egli ha la possibilità di dedicarsi con maggiore dedizione alla “ricerca della fotografia”.
THE ARMCHAIR EXPERIENCE
Non lo so se il Take Care Corner avrà un seguito. Alcuni, subito dopo la conclusione della breve ma intesa esperienza veronese, mi hanno suggerito di riproporre il Corner altrove, magari facendo spuntare poltrona e lampada in luoghi inaspettati, o in qualche piazza magari, come quel pianista che si porta dietro un pianoforte a coda sgangherato su rotelle e, infilati i guanti tagliati che lasciano le dita scoperte, sfida il rigore delle giornate più fredde per suonare qualcosa di drammaticamente sdolcinato…Ecco, magari non così!
Artribune, raccontando delle esperienze degli Independents (di cui anche Olivares cut faceva parte) ha parlato di “poltrona psicanalitica”, citando il Corner…ci sarà un fondo di verità?
Ad ogni modo, psicanalisi o no, il Take Care Corner ad ArtVerona è stato una trasposizione “in esterna” di una modalità per me indispensabile per arrivare a comprendere l’arte, che solitamente compio “indoor”: prendermi cura di un artista (cosa che spesso coincide con il “prestare ascolto”) per prendermi cura dell’arte.
Ho ascoltato per ore, giorni. E non ho voluto ci fosse nessuna registrazione audio, di quelle che non erano interviste ma conversazioni. Mi sono imbevuta di parole come una spugna con l’acqua, e ora, un po’ alla volta, dopo aver lasciato sedimentare l’esperienza, spremerò parole sulla carta, basandomi sul ricordo che ho e sugli appunti presi in pagine fitte, per scrivere quelli che non saranno nient’altro che Racconti d’arte.
Quindi comincio: il Chirurgo della luce sarà il primo, e poi via di seguito. Buona lettura.
(Ringrazio Luigi De Frenza per le numerose foto scattate al Corner che mi permette di condividere)